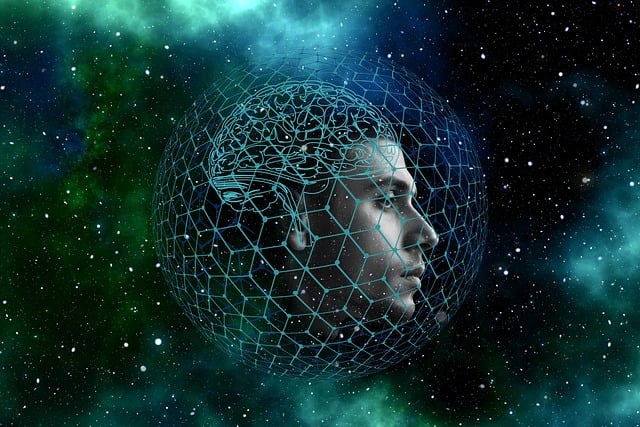La Cassazione ha affermato che, in tema di patteggiamento, rientra nel potere negoziale delle parti anche l’esclusione delle pene accessorie obbligatorie
L’accordo sull’applicazione delle pene (anche accessoria)
Nel caso di specie, il Gip presso il Tribunale di Mantova aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato la pena da quest’ultimo concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito.
Avverso tale decisione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando, in particolare, il fatto che il Gip avesse illegittimamente ritenuto di non applicare all’imputato le pene accessorie previste in materia fallimentare, nonostante l’irrogazione delle stesse sia obbligatoria.
Ammissibilità del patteggiamento cd “allargato”
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21177/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in quanto proposto fuori dai casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Sul punto, la Suprema Corte ha anzitutto ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, soffermandosi in particolare sull’esame delle novità introdotte dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1) d.lgs. n. 150/2022, che, modificando il primo comma dell’art. 444 c.p.p., ha previsto la facoltà per l’imputato e il p.m. di chiedere al giudice la non applicazione delle pene accessorie.
Ciò posto, la Corte ha evidenziato che, dalla ratio della norma, nonché da quanto indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la finalità perseguita dalla novella è sicuramente quella d’incentivare l’accesso al rito alternativo, consentendo alle parti di far rientrare nell’accordo ex art. 444 c.p.p. anche le pene accessorie, dando così luogo alla “piena negoziabilità del trattamento sanzionatorio penale nel suo complesso considerato”.
La Corte precisa, tuttavia, che la suddetta norma non impone alle parti di estendere l’accordo anche alle pene accessorie, ma li attribuisce la relativa facoltà, con la conseguenza che, se le parti nulla hanno previsto al riguardo, il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie.
Sulla base del suddetto quadro normativo, ed in particolate delle novità normative introdotte all’art. 444 c.p.p., appare necessario stabilire se l’ampliamente del potere negoziale delle parti riguarda tutte le pene accessorie, ovvero solo quelle la cui applicazione è rimessa alla decisione del giudice (e quindi solo quelle non obbligatorie per legge).
La non immediata intelligibilità della questione sopra posta, viene dissolta, ha precisato la Corte, dalla lettura del primo comma, secondo periodo dell’art. 444 c.p.p., ove la facoltà di negoziare le pene accessorie con effetto vincolante per il giudice è espressamente limitata alle ipotesi di confisca facoltativa.
Ne consegue, ha rilevato il Giudice di legittimità, che la “mancata espressa limitazione in senso analogo dell’accordo sulle pene accessorie rivela l’intenzione del legislatore di consentire alle parti di accordarsi di escludere anche quelle che devono essere altrimenti disposte obbligatoriamente”.
Sulla scorta di quanto sopra riferito, la Suprema Corte ha concluso il proprio esame riferendo che, nel caso di specie, l’imputato ed il p.m. avevano espressamente chiesto al giudice di non dare applicazione alle pene accessorie aventi natura obbligatoria in materia fallimentare, avvalendosi in questo senso della facoltà loro attribuita dall’art. 444 c.p.p., con la conseguenza che il ricorso proposto, per quanto qui rileva, non è stato ritenuto ammissibile.
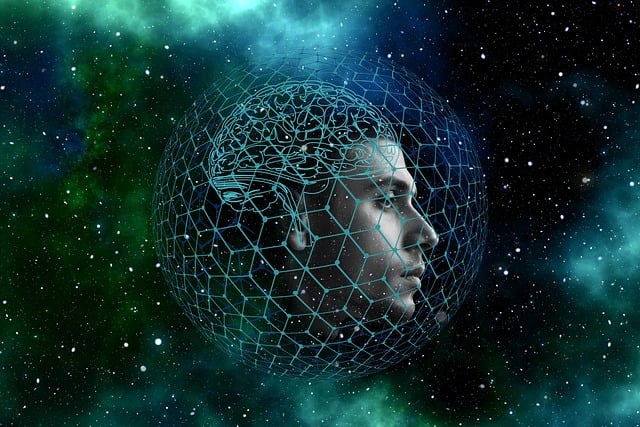
Il nuovo testo contiene norme in materia di strategia nazionale, autorità nazionali, azioni di promozione, tutela del diritto di autore e sanzioni penali
Con comunicato stampa n. 78 del 23 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Di cosa si occupa il DDL in materia di intelligenza artificiale
Il disegno di legge si propone di introdurre dei criteri regolatori volti a riequilibrare “il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso”.
Il disegno di legge introduce altresì disposizioni idonee a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, viste le potenziali ripercussioni delle stesse sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale, nonché di inserire regole capaci di offrire soluzioni per la gestione del relativo rischio.
In quest’ottica, ha spiegato il Governo nel suddetto Comunicato stampa, il disegno di legge non si sovrapporrà al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo), bensì ne accompagnerà il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno.
Quali sono gli ambiti d’intervento del DDL
Il disegno di legge ha ad oggetto cinque ambiti d’intervento: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali.
È inoltre prevista una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come “l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori”.
La delega, infine, riguarda anche la materia penale al fine di adeguare l’apparato normativo e sanzionatorio all’uso illecito dei sistemi di IA.
L’intelligenza artificiale nei settori produttivi
Il DDL stabilisce che “il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità”. È inoltre imposto il rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale.
Il Governo ha altresì previsto che l’uso dell’I.A. non deve comportare pregiudizio per la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Nella medesima direzione, il DDL ha stabilito che “L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione”.
Lo Stato promuove l’IA nei settori produttivi al fine di migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità.
Di seguito si riporta una sintetica descrizione di alcuni degli ambiti d’intervento di cui si occupa il DDL in esame.
Disposizioni in materia di sanità e disabilità
Di particolare rilievo è l’intervento del DDL in ambito sanitario e disabilità rispetto al quale viene anzitutto garantito alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione nei loro riguardi.
In tale settore, il disegno di legge stabilisce infatti che l’intelligenza artificiale non può in alcun modo “selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie”.
Il Governo si occupa pertanto di promuovere la diffusione dei sistemi di IA finalizzati “all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità”.
Di particolare rilievo è la previsione secondo cui la spettanza della decisione alla professione medica deve sempre rimanere impregiudicata.
Disposizioni in materia di lavoro
Il Governo stabilisce che in materia di lavoro si “applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea”.
Anche in tale ambito viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, dal momento che l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso produrre effetti discriminatori.
Per le professioni di natura intellettuale il DDL stabilisce che “il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale” i quali possono pertanto avere solo valore di supporto rispetto all’attività professionale.
Disposizioni in materia di attività giudiziaria
Nell’ambito dell’amministrazione della giustizia è consentito l’utilizzo dell’IA esclusivamente per finalità di tipo strumentale e di supporto, vale a dire “per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi”.
In tal senso, dunque, è sempre “riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza”.

Le Sezioni Unite ribadiscono che, per il reato di lesioni personali perseguibile a querela, è sempre competente il giudice di pace anche nel caso di malattia superiore a venti giorni
Contrasto giurisprudenziale
Nel caso di specie, una sezione ordinaria della Corte di Cassazione aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite della medesima Corte poiché aveva rilevato l’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell’individuazione del giudice competente (tra il giudice di pace ed il tribunale) in relazione al delitto di lesioni personali comportanti una malattia superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, qualora il fatto sia perseguibile su querela della persona offesa.
La sezione rimettente nell’ordinanza aveva evidenziato che la suddetta questione, pur non costituendo motivo di ricorso, poteva essere rilevata d’ufficio, posto che la decisione in ordine alla stessa avrebbe determinato implicazioni dirette sulla legalità della pena inflitta.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, la questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite era la seguente “Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita al giudice di pace”.
La competenza per il delitto di lesioni personali
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 12759/2024, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte territorialmente competente.
Per quanto specificamente attiene alla questione interpretativa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, la Corte ha evidenziato che, se “si ritiene che, per effetto della riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il reato di lesione personale perseguibile a querela, pur quando comportante una malattia di durata superiore ai venti giorni (…), la competenza sia oggi del giudice di pace, diventa applicabile un catalogo di sanzioni completamente diverso. Precisamente, (…) per i reati di competenza del giudice di pace puniti «con la sola pena della reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente (…) o la pena della permanenza domiciliare (…) ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità (..)»”.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che “Il dovere di rispettare il dato testuale della legge (…) non esclude, ma implica, la necessità di un esame coordinato della singola disposizione con altre previsioni di pari rango, anche allo specifico fine di individuare il significato e l’ambito applicativo di ciascuna di esse”.
In ragione dell’interpretazione della normativa di settore, la Corte ha pertanto ritenuto che “l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sia da leggere unitamente all’art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468, e che il perimetro del dato testuale risultante dal combinato disposto delle due previsioni normative consenta un’interpretazione secondo la quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale (..) quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”.
Ne consegue dunque, ha rilevato la Corte, che gli orientamenti che sostengono soluzioni interpretative diverse e restrittive non possono ritenersi condivisibili.
Sulla scorta di quanto sopra riferito la Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto “Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”.
Rispetto a tale principio, la Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di sanzioni applicabili “Occorre ricordare (…) che, mentre il tribunale può applicare anche le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, a norma dell’art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace non può disporre quelle irrogabili dal tribunale”.

Il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto di adeguamento della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Con comunicato stampa n. 73 dell’11.03.2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato in esame preliminare, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, un decreto legislativo “di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi”.
Prevenzione della diffusione illegale del Fentanyl e dei suoi derivati
L’approvazione del decreto legislativo di cui si è dato sopra conto, è stata preceduta dall’informativa presentata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio al Consiglio dei Ministri in relazione al “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici”, elaborato dal Dipartimento per le politiche antidroga con il supporto dei Ministeri dell’interno, della salute e della giustizia.
Il documento in questione è stato elaborato tenendo in considerazione “l’obiettivo di definire le attività di prevenzione per intercettare e impedire l’accesso e la diffusione illegale in Italia del Fentanyl e dei suoi analoghi o la sua diversione per usi non sanitari, nonché la gestione di una ipotetica emergenza”.
Nel Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici, si legge che “Il fentanyl (o fentanil o fentanile) è un potente oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico. Come analgesico, ha effetti simili a quelli della morfina, ma è da 50 a 100 volte più potente di quest’ultima e 30-50 volte più potente dell’eroina”.
Nel sopracitato Piano viene altresì riferito che “Con decreto del 30 giugno 2020, in vigore dal 28 luglio 2020, i derivati del fentanyl sono stati inseriti nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309/90), analogamente al fentanyl che era già stato tabellato”.
L’intervento del Governo
Con il sopracitato Comunicato stampa, il Consiglio dei Ministri ha rappresentato che “In considerazione dell’inserimento dei medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina nell’elenco delle sostanze per le quali vige l’obbligo di autorizzazione all’esportazione per ogni singola spedizione da parte degli Stati membri verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa, le nuove norme estendono le sanzioni penali vigenti anche alle ipotesi di esportazione di tali sostanze verso Paesi extra UE non autorizzate dalla competente Autorità italiana (Ufficio Centrale Stupefacenti)”.
In ragione di tali circostanze, il Governo ha dunque dato avvio all’iter volto all’adozione di un decreto legislativo che si occupi dell’adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (decreto legislativo – esame preliminare).

Accertamento della violazione degli arresti domiciliari di non lieve entità in base alle circostanze del caso concreto
Aggravamento degli arresti domiciliari
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame di Milano aveva confermato l’ordinanza della Corte di appello con cui veniva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari nei confronti del destinatario della stessa, con conseguente ripristino della custodia in carcere, posto che il condannato si era reso responsabile della condotta di evasione rispetto agli arresti domiciliari.
In particolare, l’odierno ricorrente era stato sorpreso nella pubblica via, dopo che si era incontrato con altra persona che deteneva sostanze stupefacenti. Dopo essere stato sorpreso dalle forze dell’ordine, il ricorrente si era poi dato alla fuga e, dopo un breve inseguimento, veniva fermato dalle stesse.
Avverso la decisione di aggravamento della misura disposta dal Tribunale, il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Valorizzazione delle circostanze della violazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8630/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Tra i motivi di ricorso, il ricorrente ha lamentato mancanza di motivazione e violazione di legge della decisione adotta dalla Corte d’appello (confermata poi dal Tribunale del riesame) nella parte in cui, nel disporre l’aggravamento della misura a carico del ricorrente, il Giudice aveva erroneamente ritenuto che allo stesso fosse stato contestato il reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/90, mentre, ha evidenziato il ricorrente, tale fattispecie delittuosa, come emerge dalla narrativa dei fatti, poteva al più ipotizzarsi a carico del soggetto con cui il ricorrente si era incontrato.
La Corte ha dichiarato tale motivo manifestamente infondato, evidenziando che “il Tribunale del riesame ha correttamente dato atto che al ricorrente non è stato contestato il reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma solo quello di cui all’art. 385 cod. pen., ritenendo che ciò non infici la decisione di disporre l’aggravamento della misura cautelare”.
Sul punto la Corte ha messo in evidenza che l’ordinanza aveva valorizzato un altro aspetto, ovvero il fatto che il ricorrente, non solo aveva violato la misura degli arresti domiciliari, ma era stato anche “sorpreso nell’attendere un soggetto, con il quale si incontrava fugacemente, risultato dedito allo spaccio di stupefacenti, ritenendo tale circostanza ulteriormente dimostrativa dell’insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni insite nella misura cautelare cui era sottoposto”.
In relazione a tale situazione, la Corte, poste le circostanze complessivamente accertate, ha rilevato come il Tribunale avesse correttamente escluso che la violazione potesse considerarsi lieve.
Rispetto alle stesse, non è stata ritenuta attendibile la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui il ricorrente, al momento in cui era stato fermato dalle forze dell’ordine, stava facendo ritorno presso la propria abitazione dopo essersi recato dagli assistenti sociali dai quali era stato autorizzato ad andare.
Tale tesi, spiega la Corte, non è stata accolta dal Tribunale dal momento che l’incontro in questione era avvenuto durante un orario incompatibile con quello in cui veniva constata la presenza del ricorrente al di fuori della propria abitazione. A tale elemento, la Corte ha rilevato come debba sommarsi anche il fatto che il ricorrente si era incontrato con un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti, configurando così una circostanza che contribuisce ad escludere, ai fini dell’aggravamento della misura, la lievità del fatto.
Sulla scorta di quanto sopra la Corte ha dunque rigettato il ricorso e ha affermato, per quanto qui rileva, che in tema di misure cautelari personali, la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove non ritenute di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dal ripristino della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo.